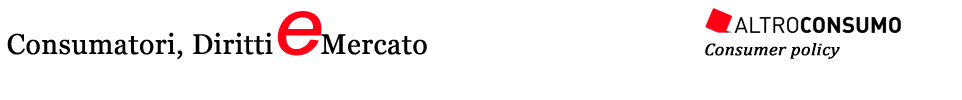Il mantra degli ultimi anni si chiama “spending review” ma si è tradotto spesso nei cosiddetti tagli lineari, in scelte assai poco comprensibili che hanno agito in maniera oltremodo grossolana su istruzione e sanità, ma soprattutto sui servizi pubblici locali. Quest’ultimi hanno molto da farsi “perdonare”: secondo la Corte dei Conti e l’Antitrust continuano spesso ad essere affidati senza meccanismi trasparenti di selezione, con una forte ingerenza pubblica che ha moltiplicato ingiustificatamente i manager o ne ha accresciuto l’indebitamento bancario per contenere gli aumenti tariffari per ragioni di consenso politico.
La manovra di autunno già fa intravedere nuovi imminenti tagli sugli enti locali che potranno trovare ispirazione dalla recente introduzione dell’Analisi dei Costi introdotta con la legge 216/2010, che ha affidato alla SOSE, società in parte di proprietà del Tesoro e di Banca d’Italia, la stima dei cosiddetti “fabbisogni standard” di un servizio. L’idea è semplice oltre che condivisibile: calcolare una sorta di benchmark per produrre un certo tipo di servizio al fine di fornire un indicatore chiaro e affidabile che permetta di determinare l’entità dei costi per funzione/servizio dell'ente locale, anche al fine di efficientarne la spesa, monitorando al contempo la performance e compararne il posizionamento rispetto agli altri enti.
I risultati, già in parte noti ma presto ufficialmente disponibili sul sito opencivitas.it https://www.opencivitas.it/, sembrano alquanto sorprendenti e delineano un’Italia diversa da quella che conosciamo. Come osservato da Stella e Rizzo sul Corriere, le evidenze di questo studio delineerebbero un “paradosso della spesa”, per cui i comuni del Sud come quelli della Calabria, spesso descritti come comuni spreconi, spenderebbero meno del fabbisogno standard di quasi il 17%, e che comuni come Casal di Principe si rivelerebbe tra le realtà più “virtuose” della Campania in base al nuovo indicatore. Di converso regioni come l’Umbria e il Veneto, o persino città come Bologna, appaiono sprecone proprio perché supererebbero di gran lunga il proprio fabbisogno standard.
E’ ovvio che non bisogna farsi ingannare dai dati e dalla recente “febbre dei numeri” della valutazione che sta contagiando ogni ambito della spesa pubblica. Seppure ispirata da principi condivisibili, la scelta di come e cosa valutare è altrettanto importante, se non di più dell’esigenza di valutazione in sé per sé. Ovvero, se la scelta di valutazione dei fabbisogni standard si concentra solo sui costi e non su parametri, in alcuni casi difficilmente oggettivabili, di qualità dei servizi erogati l’attività di analisi sui fabbisogni standard potrebbe indurre i policy makers a scelte altrettanto grossolane e approssimative come quella dei tagli lineari che hanno contraddistinto i precedenti governi.
D’altronde la stessa analisi del SoSe evidenzia che simili paradossi si giustificano anche alla luce del fatto che molti dei comuni e regioni penalizzate dalla misurazione sono anche quelli che spendono di più per i servizi sociali come gli asili, raccolta differenziata o financo per una riscossione dei tributi più efficiente.
L’idea di concentrarsi solo su una misura economicistica di un servizio locale e non sull’impatto che esso genera sul livello di benessere e della qualità della vita che determina, anche in termini di ricchezza nazionale, è un rischio più che evidente. Prendiamo proprio gli esempi evidenziati prima: nel caso degli asili nido, di una raccolta dei rifiuti o di un sistema di riscossione dei tributi più efficiente, minore spesa potrebbero significare meno donne che lavorano e meno ricchezza per il paese, oppure più malattie e degrado urbano, e di conseguenza più spesa in sanità ma anche perdite in termini di attrattività turistica o valore immobiliare di una certa area, o ancora più evasione fiscale e ingiustizia sociale.
Come osservano anche Bordignon e Turati, a queste perplessità si sommano considerazioni ulteriori che limitano il valore di tale analisi sotto il profilo delle scelte pubbliche che ispireranno, come l’esclusione delle Regioni a Statuto Speciale o il fatto che la rilevazione si riferisce al 2010, prima che le iniziative più pesanti in termini di spending review fossero operative. Inoltre, il non tenere conto della capacità di spesa e di sforzo fiscale, su cui in parte si basa la discrezionalità degli amministratori locali nella implementazione delle loro scelte politiche, significa negare la capacità di adattare quanto più possibile il proprio welare mix e le proprie strategie alle necessità e peculiarità di un contesto territoriale e dei suoi cittadini. Il rischio più grande, sulla scorta di un approccio più contabile che sostenibile, basato su una visione neo-liberista della creazione di valore, è che ancora una volta si legittimi un depauperamento dei sistemi di welfare e dei livelli di benessere complessivi della cittadinanza. Ovvero appare legittimo il dubbio di chi pensa che ricorrere ad indicatori di questo tipo, la cui ratio salvifica può essere persino caldeggiata ma non acriticamente imposta, non sia altro che la cornice giustificatrice di un ulteriore taglio lineare, non in nome dell’efficienza ma in nome delle esigenze di cassa. In un paese, il cui debito equivale a circa il 120% del PIL che ci rende tra gli Stati più indebitati nel continente anche perché con i più bassi livelli di crescita, la tentazione di correre un simile rischio appare tutt’altro che infondata.